Breve storia del saltimbanco

Nel vocabolario della Crusca, pubblicato a Venezia nel Seicento, alla voce ciarlatano si leggeva: «Colui che per le piazze spaccia unguenti e altre medicine, cava denti e anche fa giochi di mano. Coloro, insomma, che laddove la gente più s’aduna salgono sopra i banchi, palchi o panche per dispensare farmaci di varia natura, specifici contro determinate malattie, antidoti contro veleni, per cavar denti, compiere piccole operazioni chirurgiche». Evidentemente, una definizione carica di accezioni negative. Anche l’etimologia della parola ciarlatano fa capire bene il disprezzo con cui erano guardati i medici itineranti. Ciarlatano, infatti deriva da ciarla e da cerretano. “Ciarla” è parlare senza dire niente,“cerretani” sono gli abitanti di Cerreto, che a quel tempo era un «castello molto pieno di popolo», come scrisse il frate domenicano e inquisitore bolognese Leonardo Alberti, il quale aggiungeva: «I cerretani discorrono per tutta l’Italia simulando santità con diversi modi e sotto diversi colori per trarre denari». Parole che offendevano un intero paese, ma che avevano un nucleo di verità: gli abitanti di Cerreto, nella seconda metà del Trecento avevano ricevuto dal vescovo di Spoleto il permesso di cercare elemosine, con l’obiettivo di rimettere in sesto il sistema assistenziale della carità, devastato, come ogni altra cosa, dalla peste nera del 1348. Si può facilmente immaginare come molti cerretani abbiano potuto approfittare, in seguito, di questo permesso speciale, arrivando a specializzarsi nell’elemosina e nel truffare la gente in buona fede, ma è indubbio che gli abitanti di Cerreto non fossero da sempre considerati degli imbroglioni. Neppure i ciarlatani erano tutti truffatori. Anzi, molti di loro ebbero un ruolo più che dignitoso, perfino prezioso: estraevano i denti a prezzi popolari, lenivano il dolore, sistemavano lussazioni e fratture, e dispensavano medicinali che magari erano efficaci solo grazie alla suggestione, però rispondevano a necessità reali di una moltitudine di persone che la medicina ufficiale dell’epoca escludeva. Insomma, millantatori stravaganti, sedicenti guaritori, profittatori, dispensatori di miracoli e false speranze non mancavano di certo tra i ciarlatani, tutt’altro, ma gli imbroglioni criminali erano parecchi anche tra i medici ufficiali. E soprattutto bisogna riconoscere che tanti ciarlatani svolgevano un servizio utile e che, nel peggiore dei casi, sapevano almeno consolare i malati, anche i più poveri.
Se non lo conoscete già, vi presento uno di questi ciarlatani buoni. Si chiama… lasciamolo dire a lui, in un monologo immaginario: «Il mio nome è Buonafede Vitali, nacqui a Busseto il 3 luglio del 1686, alle dieci e mezzo pomeridiane, da Giuseppe Vitali e Maria Carpi. Sono un medico saltimbanco, giro il mondo con i miei rimedi e la mia compagnia teatrale, e non mi vergogno affatto di dirlo. Nei tanti anni di esercizio di questa nobile professione ho ricostruito volti, ho tolto pietre da vesciche, risanato febbri che ammorbavano un popolo intero, cavato denti, aggiustato ossa, somministrato elettuari e arcani
di mia invenzione, cerotti medicamentosi, impacchi. Sui campi di battaglia ho amputato, studiato, scoperto come cauterizzare le ferite e, come molti prima di me, di fronte al massacro mi sono arreso. Tuttavia, ne ho tratto molta esperienza. Ovunque sono stimato quale grande medico e guaritore efficace, ma, nonostante sia laureato in medicina a Catania con una dissertazione sulla natura acida del sangue
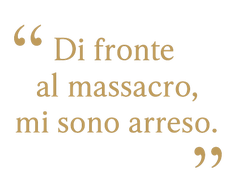
– nella quale sono riuscito a dimostrare la falsità di questa credenza – nonostante io sia Protomedico di Verona, non ho mai smesso di fare il saltimbanco, la mia onorata quanto dileggiata attività. Per la verità, preferisco la parola salimbanco, perché io sul banco, sul mio palcoscenico ambulante, non salto granché, mi limito a salirvi, a parlare alla gente che si raduna e a rallegrarla con una messinscena, spesso una commedia, insieme alla mia compagnia di attori. I signori medici teorici, non capiscono che anche lo spettacolo fa bene alla gente disponendola al buonumore, distraendola, arricchendo gli animi e rinfrancandoli; lo spettacolo è parte della cura. Sì, lo spettacolo, lo ammetto, serve anche per attirare la clientela. Ma la vera commedia la fanno altri, non io; sono i medici che non si sporcano le mani, che credono di guarire i malati recitando a memoria i loro dogmi libreschi. Io faccio arte, talvolta diverto la gente, talaltra la salvo. Ma, dal momento in cui salgo sul mio banco nella pubblica piazza e ci metto la faccia e vendo i miei rimedi a un prezzo accessibile, rimedi efficaci e certamente non dannosi, sono odiato dai medici teorici, i quali non oserebbero mai toccare un paziente, come invece faccio io. Va detto a loro discolpa che è meglio così. Sono talmente incapaci che farebbero solo del male al paziente e a se stessi; sono ben consapevoli di poter solo fallire allorquando prendessero l’avventata decisione di aprire un uomo. Al massimo possono aprire un maiale, se non sono ebrei. Ma l’uomo non è un maiale. Secondo me, un buon medico deve essere anche chirurgo, deve saper aprire le carni, togliere il male o aggiustare le ossa, richiudere e cauterizzare in sicurezza. Ma i chirurghi sono, invece, considerati inferiori al teorico, poco al di sopra del barbiere. I teorici hanno la faccia tosta di sostenere che quando sbagliano loro è colpa del malato. E no: se il medico sbaglia non è colpa del malato. E, quando accade di sbagliare, deve servire da esperimento, affinché non si ripeta. I medici ufficiali risolvono il problema con vuota erudizione, prescrivendo farmaci altisonanti e sovrabbondanti di ingredienti costosi e bizzarri; con il curare il malato tenendosi a debita distanza, avendo la pretesa di fare diagnosi e di guarire qualcuno anche da città a città, con l’ausilio della simpatia universale fra le cose; e in ultima ratio, dando la colpa al malato della sua stessa morte. La loro pomposa sapienza astratta è costituita dalla teoria dei quattro umori (sangue, flegma, bile gialla e bile nera) e da nozionismo storico e filosofico. Seguono le parole di Galeno come fossero sacre, parlano di equilibrio degli umori, tra caldo e freddo, tra secco e umido. Somministrano i cosiddetti “galenici”, preparati che, però, essi non sanno preparare, e chiedo scusa per il gioco di parole. Io, ad esempio, sono anche speziale, e i rimedi li faccio da me, con le mie mani. Forse suonerà eretico quel che dico, ma sono certo che in Paradiso si vada con le mani, non con le ali. Il principale dei rimedi somministrati dai medici ufficiali si chiama triaca, composto di un gran numero di ingredienti, fino a settanta, tra i quali il tritato di vipera. Devo riconoscere che la triaca è davvero una panacea, ma per le tasche di chi la prescrive! E i teorici la prescrivono obbligatoriamente, insieme ad altre pratiche costose. E poi prescrivono salassi e salassi, salassi da illanguidire un bue. E quando arrivo io, il saltimbanco, se non faccio il miracolo, i medici collegiati gioiscono nel vedere in me un capro espiatorio. Però non me ne rammarico quanto potrebbe sembrare da ciò che ho detto fin qui. In fondo, quando uno sta male davvero, quando è posto di fronte alla necessità e al rischio, cerca me. Sono in pochi a fidarsi dei teorici. La maggior parte preferisce rivolgersi a chi ha la pratica, a chi sa muovere le mani nel sangue, con precisione, a chi conosce i corpi, non solo i libri. Aprire e richiudere un corpo umano non è proprio come aprire e richiudere un libro. Dunque, che ridano pure di me, che mi considerino un impostore, che mi chiamino saltimbanco, per dare di me l’immagine di una scimmietta, di un arruffa popolo. Mentre loro vaneggiano, sono io che curo i loro pazienti. Ora, ad esempio, sono chiamato a Roma a curare il papa, che è affetto da emorroidi invalidanti. I potenti mi chiamano con la speranza di essere guariti. Una speranza che, spesso, è per loro l’ultima».
FD
Aggiungi commento
Commenti