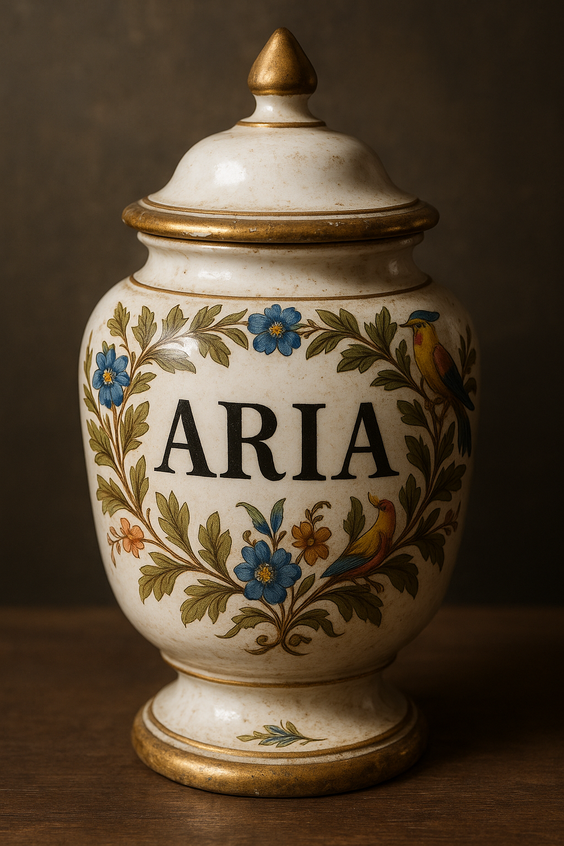
La parola più rivoluzionaria, quella che più di ogni altra ebbe a che fare con gli avvenimenti della Francia del XVIII secolo che cambiarono il mondo per sempre, non fu liberté, né egalité, né fraterinté, né ghigliottina, e neppure Bastiglia.
La parola più rivoluzionaria di tutte, forse, fu: “aria”.
Infatti, prima della Rivoluzione francese per antonomasia (1789-1799), che chiuse il secolo consegnando l’Ancien Régime al passato, c’erano state altre due rivoluzioni epocali. Entrambe riguardarono l'aria e contribuirono a preparare quella del 1789, smontando un modello culturale che era consolidato da millenni.
L'aria conquistata con... l'aria
La prima di queste due rivoluzioni, che ebbero come protagonista l’aria, avvenne il15 ottobre 1783, quando nel cielo di Metz si compì il primo volo umano a bordo di un aerostato.

Noi lo conosciamo con il nome di mongolfiera, derivante dal cognome dell’inventore, ma i primi spettatori del prodigio lo chiamarono ballon, pallone. Dentro l’enorme sacca rovesciata, a cui era appesa la navicella che, benché fosse prudentemente ancorata al suolo, portava il primo uomo nel mondo degli uccelli, a 84 metri di altezza, c’era aria calda. Perciò, quel giorno, l’impressione generale fu che l’uomo stesse conquistando l’aria, grazie all’aria. Il primo uomo a volare fu un chimico, e fisico, oltreché aerostiere; si chiamava Jean-François Pilâtre de Rozier, di Metz, ventinove anni. Il suo sogno sarebbe stato effettuare un volo libero, ma re Luigi XVI non gli aveva dato l’autorizzazione. Poi, però, arrivò, pochi giorni dopo, grazie all’intervento di François Laurent LeVieux, marchese d’Arlandes, il quale riuscì a convincere il re, a condizione che Pilâtre prendesse a bordo anche lui. Pilâtre fu felice di accettare l’offerta, e il 21 novembre i due si levarono in volo libero dai giardini della Muette di Parigi, sorvolarono la Senna e, dopo circa dieci minuti, atterrarono alla Butte-aux-Cailles, raggiungendo durante la trasvolata l’altezza vertiginosa di mille metri. Dopo di loro fu la volta di altri aeronauti, così venivano chiamati questi eroi dell’aria, osannati dalla gente che li guardava dal basso, con i volti in estasi, seguendo le lente traiettorie del pallone in uno spazio ancora vergine e sconfinato.
«È impossibile descrivere quei momenti», diceva un testimone dell’epoca. «Donne in lacrime, gente che alza le mani al cielo in profondo silenzio, i passeggeri urlanti di gioia, che si sporgono dalla navicella che ondeggia…».
L’emozione è immaginabile, o forse non più. I primi voli richiamavano migliaia di spettatori paganti. A Nantes, centomila persone piansero commosse nell’assistere a un’ascensione, e nella folla furono molti coloro che caddero in ginocchio e pregarono nel vedere il pallone rimpicciolirsi fino a scomparire in un luogo, il cielo, che era da sempre il regno di Dio, non dell’uomo.
“Lo sarebbe stato ancora? Per quanto tempo?”, ci si domandava ovunque, in quei giorni.
Erano tempi in cui, a dispetto dell’Illuminismo imperante, la maggior parte delle persone credeva ancora che il cielo fosse la casa delle divinità, il luogo da cui discendevano gli angeli e a al quale ascendevano le anime degli esseri umani (non certo i corpi vivi di uomini volanti). Così, in un’altra località della Francia, un gruppo di contadini accolse gli aeronauti, atterrati per sbaglio sul loro campo, gridando: «Siete uomini o siete dèi?», e poi scoppiarono in lacrime.
Si può ben dire, quindi, che con la mongolfiera anche il sapere e le ambizioni dell’umanità abbiano cominciato a volare. Fu una rivoluzione leggera e silenziosa, non ci fu quello spargimento di sangue che ci si aspetterebbe da una rivoluzione francese del Settecento. Se si eccettuano, naturalmente, i tanti disastri che si verificarono. Il primo incidente aereo documentato della storia riguardò proprio il primo aeronauta, Pilâtre de Rozier, che morì insieme al suo compagno di viaggio durante un tentativo di attraversamento del Canale della Manica.

Ma ormai il primo capitolo di una lunga storia era stato scritto. Da quel giorno di metà ottobre, dal volo di Metz, niente fu più come prima. La mongolfiera convinse una volta per tutte la gente comune dell’importanza della Scienza, e questo facilitò l’avvento di un’altra grande rivoluzione francese del Settecento, la cosiddetta “rivoluzione chimica”, che ancora una volta riguardava l’aria.
L'acqua, in realtà, è aria
Pochi mesi dopo il primo volo in mongolfiera – era il 30 aprile 1784 – sul Journal de Paris apparve un articolo che annunciava al mondo una grande scoperta, compiuta dal noto biologo, filosofo, economista e, soprattutto, chimico Antoine-Laurant de Lavoisier, il quale, per i paradossi di cui spesso la Storia è capace, verrà ghigliottinato dieci anni più tardi, proprio a causa delle degenerazioni della Rivoluzione francese. Sul patibolo, col pensiero rivolto a una formula che non aveva ancora finito di sviluppare, mormorò: «Che peccato!».

A ogni modo, il risultato della sua rivoluzione chimica si potrebbe riassumere così: l’acqua non esiste. Certo, non si poteva proprio dire che non esistesse, tutti potevano ancora toccarla e berla, ma di certo, affermava Lavoisier, l’acqua non era quello che si era sempre creduto che fosse, vale a dire uno dei quattro elementi di cui era composta la natura (aria, acqua, terra e fuoco). Lavoisier scoprì che l’acqua non è un elemento, è un composto di aria infiammabile (idrogeno) e deflogistica (ossigeno). L’acqua, in sostanza, non è altro che aria. La notizia scosse immediatamente il mondo intero, perché, a chi era in grado di coglierne da subito le implicazioni, quella scoperta diceva qualcosa che andava ben oltre la chimica. Ovunque, si vedevano facce attonite di fronte alla notizia sui giornali. Era chiaro a tutti che da quel giorno il mondo sarebbe cambiato, ancora una volta, inesorabilmente.
Oggi, potrebbe apparire un’affermazione pacificamente accettabile che l’acqua sia fatta di aria (o, meglio, di gas: due atomi di idrogeno e uno di ossigeno), ma per gli uomini e le donne del Settecento significava la fine traumatica di un’era. La millenaria visione del mondo, che suddivideva la realtà fisica in quattro elementi e in quattro umori (sangue, flegma, bile gialla, bile nera), sulla quale da sempre si era basata la medicina occidentale, e che fino a quel momento era considerata inattaccabile, era da abbandonare.
Dopo il primo volo in mongolfiera e dopo la scoperta di Lavoisier, tutti, non solo i filosofi e gli scienziati, cominciarono a guardare la realtà con occhi diversi e ad attribuire un’enorme importanza alla Scienza.
FD
Aggiungi commento
Commenti