Un ritratto di Niccolò Machiavelli
Benché io giudichi questa mia opera indegna di essere presentata a voi, confido che sarà ben accetta in virtù della vostra sensibilità, anche considerando che non potrei farvi dono più grande del darvi la possibilità di comprendere in pochissimo tempo tutto ciò che io ho compreso in tanti anni di disagi e di pericoli.
Niccolò Machiavelli, Il Principe

il doppio volto dell’uomo e del pensatore
Niccolò era passionale, burlone, amichevole, un tipo alla mano. Machiavelli, invece, era un freddo calcolatore, astuto e spietato, se occorreva, ed era un provocatore nato; soprattutto, provocava sempre le persone sbagliate. In Niccolò Machiavelli coesistevano queste due opposte personalità, che a volte si scindevano. Gli amici cercavano di conciliarle nel soprannome con il quale lo chiamavano bonariamente: il Machia. Ma non ci riuscivano, lui sfuggiva sempre alla loro comprensione. Era un po’ come l’Italia, che non si riusciva a fare unita. Con questo sogno in mente, unire l’Italia, ha lavorato fino alla fine dei suoi giorni.
La storia come laboratorio dell’azione politica
Machiavelli era convinto, in modo decisamente esagerato, che la storia sia maestra delle nostre azioni, che insegni come bisogna agire nel presente. Per lui gli uomini sono uguali in tutte le epoche, soggetti alle medesime passioni; perciò, a una determinata situazione può corrispondere la stessa reazione che ha avuto successo nel passato. I precedenti storici sono una sorta di legge impeccabile. A volte, Machiavelli era come abbagliato da questa convinzione. Era ammirato dagli esempi politici e militari dell’antica Roma repubblicana, convinto che bisognasse imitarli: dato che erano stati i padroni del mondo, occorreva prendere esempio da loro per imparare a governare; però, sottovalutava il peso delle novità del presente, come ad esempio l’introduzione dell’artiglieria mobile, che stava cambiando il modo di fare la guerra.
Firenze, tra orgoglio e disillusione
Niccolò Machiavelli era molto orgoglioso della sua Firenze, centro di eccellenza artistica, culturale ed economica. Un laboratorio di modernità, in cui si sviluppavano strumenti innovativi per il commercio e la finanza. Una città sfavillante di meraviglie, piena di artisti di valore e grandi pensatori. Machiavelli ammirava anche i fiorentini, che avevano saputo diventare maestri dell’arte della tessitura, dell’attività bancaria e del commercio; che avevano portato in Italia i numeri arabi; che avevano inventato la lettera di credito e prodotto la prima moneta d’oro del mondo: il fiorino — un fiorino, al tempo di Machiavelli, conteneva 72 grani d’oro esatti ed era il mezzo di scambio preferito in Europa. I veneziani, quando avevano creato il loro ducato, lo avevano fatto identico al fiorino, con lo stesso contenuto d’oro, in maniera tale che le due monete fossero intercambiabili.

Dei fiorentini, Machiavelli ammirava anche la prudenza, la precisione, l’importanza che attribuivano a una reputazione onorata, tutte cose che essi avevano imparato dall’esperienza mercantile: i fiorentini erano diventate persone oneste, precise e caute per mero interesse personale, per saggezza dovuta a una lunga esperienza. Inoltre, Firenze si era conquistata con le armi la propria libertà ed era divenuta una repubblica, dove la nobiltà feudale non aveva più diritto di cittadinanza, mentre quasi tutte le altre città italiane erano cadute nelle mani di una qualche famiglia di tiranni.
Però, a giudizio di Machiavelli, Firenze aveva anche gravi difetti: non pagava degnamente e con puntualità chi lavorava al suo servizio, e specialmente si comportava male con i condottieri che assoldava, e per questo era considerata infida. Insomma, questa mania tutta italiana di usare i condottieri per fare una guerra finta, a Machiavelli non piaceva per niente.
I condottieri e la crisi della guerra italiana

In un contesto in cui la nobiltà feudale era stata estromessa e la borghesia non voleva combattere, la difesa armata diventava un mestiere da delegare ad altri. Così facendo, le città italiane perdevano la loro forza militare e la possibilità di difendere le proprie istituzioni.
Machiavelli era persuaso che solo una milizia cittadina, fondata sull’interesse pubblico e non sul profitto privato, potesse garantire la libertà repubblicana. E questa convinzione attraversa tutta la sua riflessione militare e politica.
Si chiamava “condotta” il contratto di assunzione di un capitano di ventura o condottiero. Questi signori della guerra erano mercenari che si vendevano al migliore offerente e agivano con crudeltà e senza scrupoli, cambiando rapidamente alleanze; spesso accettavano la lucrosa condotta da una città e poi si facevano pagare dagli avversari per non attaccare. Era un mestiere estremamente redditizio. Le famiglie di condottieri si legavano fra loro in una rete di matrimoni per creare alleanze: solo i rampolli di queste famiglie potevano ambire a diventare capitani di ventura. Ma essere un condottiero non richiedeva necessariamente coraggio o capacità: nel sistema che si era creato in Italia non avevano bisogno di appassionarsi alla causa di chi li assumeva o di rischiare la vita; era più facile venire assassinati in casa da un familiare che non sul campo di battaglia; le guerre fra italiani, prima dell’arrivo degli eserciti stranieri (da re Carlo viii in poi), erano ritualità nelle quali si cercava di non correre rischi e si faceva il possibile per non arrecare danno ai civili. Machiavelli era convinto che questa fosse una delle cause del male italiano: il cinico interesse personale di questi mercenari, di cui i ricchi mercanti e banchieri di Firenze si avvalevano, non volendo mettersi in armi personalmente e non capendo l’importanza di istituire una milizia dello Stato. Una milizia composta da cittadini e non da predoni infidi, inaffidabili e pericolosi, che non disdegnavano di tenersi le conquiste fatte e, forti di queste, neppure di muovere guerra a chi li aveva assoldati.
Il sogno spezzato dell’Italia unita
Machiavelli era angosciato dalla situazione italiana: l’Italia aveva tesori immensi, straordinari, ma era assurdamente incapace di difenderli. Gli stranieri — dai francesi di Carlo VIII in poi — lo avevano capito perfettamente: era di vitale importanza unire l’Italia e far sì che diventasse un grande Stato con un grande esercito. Ma sebbene gli italiani fossero consapevoli che soltanto collaborando avrebbero potuto sopravvivere all’invasione dei cosiddetti barbari, si erano convinti che fosse assurdo fidarsi l’uno dell’altro.
Dopo il 1513: la solitudine e la scrittura
Dopo la caduta della Repubblica fiorentina e il ritorno dei Medici, Machiavelli viene estromesso da ogni incarico. Vive isolato, sta toccando il fondo. Non è più il segretario della Repubblica di Firenze. Trascorre le giornate nella villa lasciatagli in eredità dal padre, a Sant’Andrea in Percussina, fra i boschi, o all’osteria, e vive come un villano. Tutto il suo sapere non interessa ai potenti Medici, non interessa a nessuno. Machiavelli non guadagna denaro, ma è abituato a spendere molto, e quindi è diventato un peso per la famiglia; vorrebbe perfino inscenare la propria morte e andarsene per sempre. Per nostra fortuna, proprio in questo periodo oscuro scrive Il Principe: un trattato lucido, spietato, realistico, pensato non per la gente comune, ma per un governante che voglia fondare o conservare lo Stato. Non è un manuale di immoralità, bensì un tentativo estremo di rimettere la politica al centro della storia.
Contrariamente a quanto si dice, Machiavelli non scrisse mai che "il fine giustifica i mezzi" in modo assoluto. Se il fine è il bene pubblico — pace, giustizia, prosperità — allora i mezzi necessari possono anche essere duri. Ma mai arbitrari. È una concezione etico-politica, non nichilista.
Gli insegnamenti di Machiavelli non vogliono essere il modo perfetto di comportarsi per avere successo nella vita quotidiana: sono rivolti a un capo di stato, elaborati sulla base della sua lunga esperienza di Segretario (diplomatico) inviato presso le corti straniere, e raccolti in un libro con freddezza e realismo, a uso politico e strategico. Quando, ad esempio, Machiavelli parla dei "cervelli inutili", si riferisce a certi sovrani e intende dire che con costoro è inutile discutere; non sta dicendo, dunque, che gli tutti gli stupidi del mondo devono essere eliminati, come qualcuno malevolmente interpreta, piegando il vero insegnamento di Machiavelli a scopi per i quali non era stato concepito. Machiavelli non ha mai detto, né pensato, che il fine giustifica i mezzi. Mai. O meglio: il fine giustifica i mezzi, sì, ma solo quando il fine è: il benessere e il benestare dei cittadini; la giustizia; l'armonia; la ricchezza materiale, culturale e spirituale; la pace.
Qui di seguito, alcune sue folgoranti massime.
FD
Massime per il potere (e anche un po' per la vita)
*
Nacqui povero, e imparai prima a stentare che a godere.
*
Ci sono tre tipi di cervelli: quelli che capiscono da soli, quelli che capiscono con l’aiuto di altri, e quelli che non capiscono né da soli né con l’aiuto di altri. I primi sono eccellentissimi, i secondi eccellenti, i terzi inutili.
*
Le ingiurie si devono fare tutte insieme, affinché, assaporandosi meno, offendano meno; i benefici, invece, si devono elargire a poco a poco, affinché si assaporino meglio.
*
Se possibile, non ci si deve mai separare dal bene, ma quando è necessario bisogna saper entrare nel male.
*
È saggio presumere che gli uomini siano tutti rei, sempre pronti a usare la malignità dell’animo loro ogni qualvolta ne abbiano l’occasione.
*
È meglio fare e pentirsi, che non fare e pentirsi.
*
Il vero saggio è colui che di fronte a due possibilità sa scegliere quella che, se le cose vanno male, comporta il danno minore.
*
Ai principi e alle repubbliche prudenti deve bastare vincere; perché il più delle volte, quando non basta, si perde. Spesso questo accade a causa di una insolenza che ti dà la vittoria.
*
La Fortuna è importante, ma non bisogna farci troppo affidamento. È necessario essere abili per sapere sfruttare le occasioni quando si presentano. Insomma: senza le occasioni le capacità vanno sprecate, e senza le capacità le occasioni arrivano invano.
*
Gli esseri umani odiano le imprese che appaiono difficili.
*
Le persone che sprecano la propria vita senza fare niente di utile o di importante, i nemici delle virtù, delle lettere e di ogni altra arte che arrechi utilità e onore all’umanità sono infami e detestabili, come gli empi, i violenti, gli ignoranti, gli oziosi, i vili.
*
L’iniziativa e l’azione sono condizioni necessarie al successo; la neutralità e le vie di mezzo sono fatali.
*
Gli uomini sono sempre increduli e sospettosi di fronte alle novità, a meno che non siano consolidate dall’esperienza.
*
I profeti armati vincono sempre, quelli disarmati falliscono.
*
Gli uomini si devono o vezzeggiare o annientare, e ogni altra via è pericolosissima. Con i ribelli domati ci si deve comportare in due modi: o guadagnarsi la loro lealtà dandogli dei benefici o trattarli in modo che non possano nuocere mai più. I Romani lo facevano distruggendo le città ribelli e trasferendo gli abitanti a Roma, oppure eliminando gli abitanti e sostituendoli con gente nuova, oppure lasciandovi i vecchi abitanti, ma inserendovi tanta gente nuova da rendere impossibile macchinare azioni contro il Senato.
*
Meglio puzzare di merda che di bischero.
Il mio romanzo su (e con) Niccolò Machiavelli

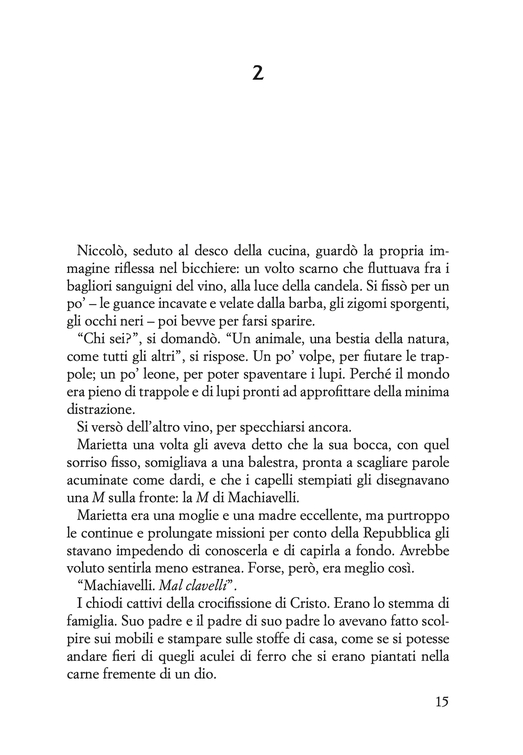
Niccolò Machiavelli offre molti spunti a un autore di thriller storici. Quando ho scritto L’inganno Machiavelli, però, il mio intento non era solo creare una sotria mozzafiato e misteriosa, ma anche avvicinarmi (e fare avvicinare il lettore) a un uomo del quale spesso si ha un’immagine distorta o ridotta all’essenziale: l’autore de Il Principe, il teorico del potere spietato, il simbolo del cinismo politico.
Io volevo parlare del Niccolò Machiavelli uomo, immerso nella realtà del proprio tempo: osservatore acuto, diplomatico instancabile, servitore della Repubblica, marito, padre, corteggiatore, pensatore inquieto, capace di domandarsi con lucidità se il male fosse solo una componente politica o qualcosa di più profondo.
L'inganno Machiavelli si sviluppa attraverso la Firenze del 1503 e poi la Roma del conclave, in un contesto segnato dalla violenza, dalla superstizione e da una crescente tensione politica. Machiavelli viene incaricato di indagare, in segreto, sul misterioso “Belfagor”, che potrebbe essere un principe, un criminale o… un diavolo.
Ma più che la ricerca avventurosa di un colpevole, il romanzo è il racconto di un tempo e di un pensiero. Ho voluto far emergere l’uomo dietro le idee, il funzionario dietro l’autore, il marito che parte mentre la moglie sta per partorire, il testimone della crudeltà del potere, che lui cerca ancora di servire con razionalità e rigore.
Scrivere questo libro è stato un bel viaggio, per me, un modo per abitare un po’ la mente di Machiavelli, camminargli e corrergli accanto nelle sue contraddizioni e nelle sue straordinarie intuizioni.
Aggiungi commento
Commenti